
La scrittura del rimosso.
Su spazio di destot di Fabio Teti
di Luigi Severi
crâne abri dernier
pris dans le dehors
tel Bocca dans la glace
(Beckett)
Fai torto a me, ma è lui che trascini in catene
(Euripide)
- spazio di destot di Fabio Teti ([dia•foria, 2015) è un libro difficile, quasi dilaniato da contenuti incandescenti, ma gestito da un ordine rigoroso, in forza del quale lo spazio della scrittura, a partire da un percorso di desoggettivazione, arriva a dare un rilievo incendiario a elementi primi, realia caduti dal discorso individuale e collettivo: dal passo implacabile della metamorfosi, alle ferite della storia, ai difficili medicamenti.
Scrive l’autore, nella parte finale del libro: «è sempre per essere vero, che faccio il mio incubo». Proprio la vista di ciò che è stato rimosso, e che la parola può riportare in superficie, potrà forse un giorno rendere di nuovo pronunciabile (vero) l’essere in vita in quanto essere umano.
- In questo senso, a costo di eccessivo didascalismo preliminare, va cercata in un filosofo come Lévinas, decisivo per molta poesia contemporanea, la prima chiave d’accesso all’opera di Teti. I seguenti punti valgano dunque come prima mappa per il territorio complesso di spazio di destot.
a. «Essere responsabile al di là della propria libertà non è certamente restare un puro risultato del mondo», si legge in Altrimenti che essere Lévinas. Questa intenzione, questo atto di responsabilità verso l’altro, consapevolmente assunto nella scrittura (in quanto modalità di esistenza), sembra alla base di tutto il lavoro di Teti.
b. Per questa ragione la scelta della forma non può accontentarsi di soluzioni date. Ancora Lévinas: «Questa dedica all’altro, questa sincerità è il Dire. Non comunicazione di un Detto che subito ricoprirebbe ed estinguerebbe o assorbirebbe il Dire, ma Dire che mantiene aperta la sua apertura, senza scuse, senza evasione né alibi». Insomma, l’urgenza di un dire che si esponga al di là della soggettività, ma che non si affidi a formule note, che non affondi in un già detto, coi rischi foucaultiani di una parola che parla il dicente. Un’evasione dal cerchi del sé ma anche dal noto, dal luogo comune, dalla resa che implica.
c. Di qui l’invenzione di un dire che si apra di passo in passo, esponendo la propria tensione, giocando tra detto e non detto, tra inconscio proprio e collettivo: «È l’estrema tensione del linguaggio, il per-l’altro della prossimità; della prossimità che da tutte le parti mi circonda e mi concerne fino nella mia identità e il cui logos avrà già disperso il potenziale giocando fra le coppie: conscio inconscio; esplicito implicito». Proprio la tensione del linguaggio e lo sforzo di muoversi dentro gli spazi che allacciano l’inconscio privato con l’inconscio pubblico (e la pubblica rimozione), è ciò che rende precisamente necessaria la forma in spazio di destot. Probabilmente sperimentale, se ancora ha un senso, più che di un primo orientamento, l’uso di simili etichette. Una cosa conta di certo: che in questo libro la scrittura giustifica la sua forma (e le sue tradizioni di riferimento) attraverso il percorso di pensiero che la determina. - Forma – e metodo con cui la forma si fa – sono, in spazio di destot, tutt’uno con l’orizzonte di senso suscitato. Il metodo è l’autore stesso a raccontarlo, in una sua lettera all’editore (Daniele Poletti), che Andrea Raos, nella sua postfazione, cita direttamente. Tutto nascerebbe da un nucleo di testi segnati da incandescenza etica, sovra-esposti e sovra-espressivi, a orecchio dell’autore. Questi testi ad alta temperatura retorica sono stati così sottoposti, in tempi diversi, a due procedimenti riscrittori, alla base delle due sezioni del libro. Disfazione, la prima, nasce da un processo di franamento, sottrazione, fessurazione attraverso un drastico cut up affidato a un software, con successivi interventi compensatori. Diversione, la seconda sezione, nasce invece da una sollecitazione per così dire centrifuga: da un procedimento, cioè, di iper-traduzione dei testi attraverso Google translator (ottenuta «riportando il tutto in italiano dopo diversi passaggi tra le lingue»: così l’autore). Si tratta quindi di un’operazione non più in levare, quanto di ristesura in una lingua quasi pacificata sul piano sintattico, ma divenuta del tutto lingua altra. A cerniera tra le due parti: una poesia in qualche modo tradizionale, in distici irregolari. Molteplici però sono gli ulteriori elementi di struttura cooperanti al testo.
a. La poesia – cerniera (che di per sé ha un valore riparativo, di rinnovata affabilità e possibilità verbale) è conficcata come un chiodo (il sèma della crocifissione – come persecuzione e al tempo stesso riparazione di una colpa altrui – è fondativo del testo) tra un’immagine dell’ulna e una del radio.
b. Essenziali alla comprensione anche le due epigrafi. La prima («sei lui, ti credi te») dalla montaliana Serenata indiana, ci riporta alla perdita di identità cosciente (alla confusione io – lui) che consegue ai vortici della storia. La seconda («More is what ensues when it is no longer the same») da Four Lectures di Stephen Rodefer, allude all’intensificazione di stato che deriva dal mutamento, dal non essere più se stessi. c. Questa idea, che prelude al bagno iperlinguistico della seconda azione / sezione, viene subito messa in pratica come iper-accoglienza, condivisione, moltiplicazione di mani e strati. Si infittiscono, quasi soffocanti, le penne e i pennarelli a commento: Andrea Raos e Simona Menicocci ricoprono di glosse e interazioni il bianco delle due pagine affidate alle epigrafi, contribuendo a creare un movimento di pluralità verbale, quasi una mimesi verbigerante dell’atto, caoticamente collaborativo, di ogni poiesi, nata dal commento di cose già dette, ma viva proprio per questo: perché comune.
d. Identica la strategia collaborativa della chiusa, in cui Raos e l’autore, per dir così, si convocano a vicenda (e richiamando Achmatova e Mesa, Raos comunica la direzione, la genealogia etica in cui la scrittura di Teti si colloca).
- È proprio Raos nella postfazione ad annotare che Teti, nella stessa lettera a Poletti, si augura «di essere riuscito ad aggirare il “dispositivo identitario” insito nella scrittura».I testi centrati sul “dispositivo identitario”, cioè su una postura d’autore, avvertita come tirannica, sono quindi lasciati nell’ombra, in una zona premessa ma invisibile – e non a caso le due sezioni poco sopra descritte, disfazione e diversione, sono numerate come 2 e 3, la prima consistendo nell’atto autoriale tradizionalmente inteso. Questo allontanamento dalla propria scrittura, di una fase ancora troppo soggettiva, diventa così il motore di un’invenzione, di un’intenzione di scrittura capace di parlare per l’insieme, e solo di conseguenza per l’individuo.
Due obbiettivi in uno:
a. La scrittura arriva a esplorare le radici comuni del «linguaggio stesso, che è forse il più antico dei dispositivi, in cui migliaia e migliaia di anni fa un primate ebbe l’incoscienza di farsi catturare» (Agamben), con tutti i residui di storia che nella langue si depositano senza omissioni (ma con rimozioni). In altri termini, il dispositivo identitario si trasmuta, per forza di impulso solo mediatamente soggettivo (autoriale), in dispositivo linguistico, di un linguaggio cioè che si rivela essere oscuramente (cioè per intervalli d’afasia) comune.
b. Per questa via, la scrittura dà voce al rimosso, disperso nell’imperio dei dispositivi dell’ultima modernità, definiti proprio dal fatto che «non agiscono più tanto attraverso la produzione di un soggetto, quanto attraverso dei processi che possiamo chiamare di desoggettivazione», disinnescante ogni singola coscienza ed intenzione (ancora Agamben). La transcodificazione del discorso d’autore in discorso il più possibile desoggettivato, proprio attraverso un dispositivo tecnologico (vettore di un inconscio comune), penetra così il dominio della téchne dall’interno, rendendo quasi naturale la pronuncia dei mali storici ad essa connessi (quella distruttività già così bene prefigurata, sul limitare della modernità, nel Daedalus baconiano).
- Questo continuo trascorrere da spazio singolare a spazio comune è ben impresso nel titolo. Il cosiddetto “spazio di Destot” è infatti una zona del polso, nota, più che per ragioni anatomiche, perché usata di preferenza per conficcare i chiodi della crocifissione. Questa zona del corpo è immediato simbolo del nesso tra esistenza individua e tragedia collettiva. Nella nominazione di un luogo corporeo non solo personale, ma anzi segnato da una brutalità che si è fatta storia, si apre la possibilità di una parola inclusiva, moltiplicante, sforzata a racchiudere altro: a tradurre altro in sé, attraverso una vera e propria verbigerazione di segni ipersignificanti.
- Il libro si fonda in effetti su un continuo trapasso traduttivo. «Tutta la poesia infine è traduzione», scrive con celebri parole Novalis a Schlegel, cogliendo il centro di una pratica etica di traslitterazione di codici differenti in unico discorso, che avrà nel Novecento il suo tempo più consapevole, in quanto adozione o reinvenzione di un idioma altro dal proprio, sempre infido (Muttersprache Mordersprache), da Celan alla Kristoff. In Teti, la traduzione procede da una lingua propria a una diversa lingua propria – ma più fessurata, che neghi il limite, lo introietti e rigetti al tempo stesso, in uno sforzo titanico di passaggio verso l’altro. Viene in mente la celebre lettera di Freud a Fliess (6 dicembre 1896): «al limite di ognuna di queste epoche [di sviluppo dell’individuo] si deve verificare una traduzione del materiale psichico». Con una conseguenza: che errori o omissioni di traduzione comportano strappi nel testo psichico di arrivo, con conseguenti necessità di compensazioni.
In questo senso Teti in disfazione traduce i materiali di un io nutrito di collettività procedendo a ritroso, verso una fase del tutto asintattica, pre-logica. Meglio: verso quella fase che Bodei chiama paleo-logica, che precederebbe la logica aristotelica del senso comune e del ragionamento, fondata sui principi di identità, non contraddizione e terzo escluso. Questo meccanismo, destabilizzando alla radice il verbum, arriva a sottrarlo al legame genetico con un io qualsivoglia, tanto più se in qualche modo prepotente, quale doveva essere, per pretesa assoluta, nei testi di partenza. Destabilizzandolo, lo rende poroso, lacerato, dolorosamente disposto al mondo.
Sulla pagina si depositano così, in totale devastazione morfologica, in regime afasicamente regredito ad assoluto asintattismo, nomi essenziali, tessere ipersignificanti, intensificate dal loro valere come note isolate e prolungate, cadute come frantumi di una civiltà ipersatura, esplosa o sul punto di esplodere per eccesso di ragionamento, che è poi tutt’uno con un difetto di umanità (Vico). Da ciò traggono la forza di cristallizzare temi e contrasti originari, perfettamente eraclitei. Muovendosi infatti dentro questa paleo-logica regressiva, di tipo nevrotico-infantile, altissimo è il loro tasso di polarizzazione semantica (come spiega il classico Bruno Bettelheim del Mondo incantato), con continuo impatto di antitesi, quando non di ossimoro: «una corda in un, incidente, e adesso la mia nascita»; «pericardi laciniati, o un arto partorito» (dove il botanico laciniato richiama evidentemente, in logica di linguaggio onirico, lancinati, in contrasto parziale col successivo arto partorito: parziale, perché il parto di un arto è in sé allusione a membra irrimediabilmente disiecta); «effetto t’accorgi, è respirare. lì dall’umore – lame, siano schizzo d’un siano, lame sull’ombelicale»; «il rotte acque, sistemi non, smembra» – dove l’immagine della nascita è accostata, anzi identificata con il trauma, lo smembramento; ecc.
- In realtà ogni tessera lessicale, isolata e scandita dallo slogamento sintattico, ma in questo modo immessa in accostamenti secchi, di primitivo impatto semantico, è irretita in una morsa ossimorica. In particolare, questo è vero per quei nomi di ambito fisiologico, medico, biologico, riportati a una dimensione immediata, a una funzione prima di tutto fonica di rappresentazione brutale della materia vivente: flebotomi, catabolismi, metastasi, ecc., punteggiano ossessivamente il testo, in un ritmo battente, visivo di disfacimento, sempre però ricondotto, per salti improvvisi, alle ragioni della storia – come nel caso più rappresentativo, perché legato al titolo: «il radio il vuoto, ulna, e non inchiodi».
Se tutto entra in una scintillazione di contrasto originario, fondato su archetipi biologici e solo poi sociali, è inevitabile il dominio di riferimenti al nascere e al farsi della vita (seppure intesa come guerra): menorrea, ovulazione, amniotico, placenta / placentare sono lessemi ricorsivi, così come l’immagine oscura della fecondazione («l’inombra nell’utero che seme»).
La vita è un compito non scelto e arduo da tenere insieme, e il corpo (anche della lingua) ne è lo specchio: «vita scelta, non, frantumi». Frantumi, scorie, molecole, scaglie («tuo franto se esulcera le discagliate»): un ridursi a principi primi che è presa di coscienza feroce e non ragionata, originaria e disseccata come un De comptentu mundi estremo e (anti-) profetico. La discesa nella decomposizione umana (che, di nuovo, è decomposizione della lingua) precipita entro anatomie insistenti e allucinate, cui il linguaggio medico aggiunge la vertigine della spersonalizzazione ultramoderna. E come la tensione del Comptentus di Lotario era nutrita di una catastrofica tensione ascetica (ma al tempo stesso etica), così l’elemento ipervisivo della corrosione che fa la disfazione di Teti tende ad altro: a uno spirito profetico rifluito in se stesso, immune da trascendenza, tutto rivolto al perimetro di uno spazio insieme di visione e di realtà. In linea col profetismo novecentesco, il linguaggio decomposto di Teti «non pensa, come quello platonico, di possedere una verità concettuale universale ed eterna. Esso riceve soltanto un messaggio per una situazione […] Esso non pone davanti agli uomini alcuna immagine universalmente valida di perfezione, nessuna pan- o u- topia […]; è assegnato per la realizzazione a questo topos, a questo luogo» (così Martin Buber). La parola, regredita a nominazione franta, si spinge a vedere dove la vista ordinaria non vede; nascendo da interstizi, sconnessure, spacchi inosservati, vi getta intermittenze di luce – e non a caso il tema dell’occhio, della sua ferita possibile, della sua sottrazione, è qui portante.
- La vista, ferita o no che sia, deve infatti fissarsi a questi frantumi storici affioranti, che ripullulano da luoghi della storia inferici, sommersi. Ecco allora le continue immagini di dissezione di cose e corpi («le limoni danneggiati a morte, di intreccianti, sull’asfalto»). Ed ecco il richiamo a Falluja (le stragi del 2004; le armi non convenzionali; i crimini contro l’umanità lì perpetrati, nel silenzio globale): «sarcofago sillabico, tortura, strada per falluja, nient’altro e nerofumo».
Per questo il tono è tutto infernale. Da Inferno dantesco: e non a caso Dante, quello di Malebolge ma non solo, fa da continuo sottotesto. Nelle dissezioni a sguardo fermo è spesso presenteInf. XXVIII (per es.: «e morire, paralisi da o senza generale, ogni sciami cervella», con richiamo al «porto il mio cerebro» di Bertran de Born); ma, di là delle citazioni puntuali, è la voce, il suono tagliente e brutale, prodotto da risentimento etico, che riporta l’attraversamento infernale al controluce dantesco:
trattenere di nulla il proda che, il non, il dito pietra, crono. e se marmo bolge muta, calpesti, della osceni, l’udito, s’incroia, dì e scemi botro di cruentare, catacomba. il nel e il dito tremore: nulla carbonica pneuma possono questi, reflui, sabbie, croda trattenere e il crono e proda ratto, trattenere il dolore: cardini
Siamo di fronte allo squadernamento di una tavola chimica dei principi umani in atto nel farsi della storia. Chiaro che il mito di una qualsiasi Maat, divinità dell’ordine cosmico e della giustizia, appartiene al passato («troncamento di per piuma, maat, in sì che è volto ed è sclerotica»); ogni ipotesi utopica, ogni rimanenza di idea platonica è spazzata via, tutt’al più ricondotta a una necessità violenta di metamorfosi: «lebbra sbobina, le scaglia, platone, caverna non vuoto crepuscoli, spiega, soliloquio, caverna la e di metamorfosi». Ma la coscienza di una legge fisica di metamorfosi, seppure ferma, non può tuttavia essere in nessun caso l’approdo ultimo, perché sostanzialmente differente dalla questione morale, assai più bruciante, della scelta e del male – e perché d’altra parte il rifugio in essa è stata, ed è tuttora, alibi e arma per le derive à la Sade («l’intercapedine poi solo in è, chiodi in frenata. dai sade, marchesi»), inflitte nel corpo della storia ben oltre i paradossi del filosofo francese («se è la voce della natura a suggerirci odi personali, vendette, guerre, insomma tutte le cause tipiche dell’omicidio, vuol dire che ne ha bisogno» ecc.; Encore un effort).
In disfazione insomma non c’è mai traccia di rassegnazione, quanto piuttosto un corpo a corpo con le cose umane che ha, fin dall’inizio, valore di scelta. Per questo la visione si apre in uno spazio di incessante rimbalzo tra le cose, ridotte a frantumi, e un tu fluttuante e straniato, ma battente come un ritmo al fondo vitale («tu qualunque», «tu feromone», «tu disabilita», ecc.). Uno spazio in cui il solo nominare l’altro è già assumersene la responsabilità. È proprio in virtù di questo accanito moto di inclusione e di visione che, dalle plaghe infernali della memoria, emergono a tratti anche spie, del tutto contrastanti, di una diversa possibilità storica. L’ipotesi stessa di una qualche speranza, ad esempio: «Sperare e cappio», «sperare spirare»; e persino di una qualche verità: «a bilancia sull’asfalto spalpebrata, verità, è sul troncamento». Dalla dissezione, dal fondo del suo contemptus mundi, Teti scopre, e indica in fine, la via per ricostituire il senso dell’umano:
vita è il con; tutto questo allora tumulare.
Il corsivo (dell’autore) scandisce a parole decise che è l’essere-con (per riprendere la formula di Jean-Luc Nancy) il risarcimento per tanto atroce «tumulare» (della storia): l’aggrapparsi al legame con l’altro, come a una vita nuova.
- È il con a risvegliare infatti la «vera infanzia del possibile», recuperando uno spazio, «un lembo strappato dal mentito dei limbi», come recitano due versi della poesia posta a cerniera. La disfazione può diventare così diversione, ovvero deviazione (dalla norma), strada altra, fondata sul continuo vertere, sul tradurre (l’esperienza in lingua, la lingua in altra lingua, ecc.), che è poi breccia fondante della comprensione.
È questa dunque la via che Teti imbocca per arrivare a un logos capace di procedere verso l’altro da sé, secondo regole non più del tutto paleo-logiche, ma stavolta di logica abnorme, fuori misura. Scrive Wittgenstein, altro autore fondamentale per Teti (vedi ad es.: «di ciò – di cui non si può dire | non sa dire», da Btwbh): «Si diceva una volta: Dio può creare tutto, ma nulla che sia contro le leggi logiche. – Infatti, d’un mondo illogico noi non potremmo dire quale aspetto esso avrebbe». Tuttavia, quel che cerca Teti in diversione è una lingua alluvionale, quella specie di lingua ultima «che trascina / le scorie a storia» (ancora da Btwbh). Per evitare però le secche tiranniche di ogni discorso reificato, quindi ridotto a parole monadica, Teti sceglie la rotta del vertere: ricollocare logicamente il discorso facendolo passare per un bagno di più lingue, in un movimento babelico che di per sé mira a intridere la propria lingua con quella di altri, presenti in altri tempi e in altri luoghi.
Inevitabilmente ne esce una lingua monstre: ora pacata; ora ricca di connettivi e di formule di trapasso logico; ora piena di faglie, cambi di progetto, omissis, sia pure dietro un’apparenza di ordine sintattico. Ma se «la proposizione è un’immagine della realtà», come voleva Wittgenstein, è chiaro allora che questo discorso sempre deragliato, tutto impastato di un inconscio plurilingue mediato dal dispositivo che per eccellenza interpreta e condiziona il nostro tempo (Google), ha il passo glossante (le acque del commento, recita il sottotitolo), il movimento imprevedibilmente associativo, ma anche l’improvvisa accelerazione di verità frontalmente nominata che sono tipici del linguaggio schizofrenico, il codice più veritiero del moderno, adottato in modo compiuto dal Beckett di Watt, e verificato da Jameson, alle soglie del neocapitalismo, come discorso del mondo per eccellenza. Sin dalla frase di apertura di diversione ci siamo dentro:
ha dovuto lasciare, poi torcere, la sua abitudine a essere nato. ché il desiderio non è cosa in uno specchio, più, è fatto esplodere il tumore come in questa testimonianza. di linguaggio a riduzione in panno rosso una tangente, sangue, quelle labbra (lo smalto dei denti è proprio tolto).
Quella materia di scarti urticanti che era stata drenata in superficie da disfazione, ora, nella logica pluritraduttiva di diversione, si dispone secondo differente amalgama. Qui ad esempio i frantumi medico–anatomici, là dominanti, sembrano quasi disciolti in una soluzione più fluida, in un clima meno sulfureo e più falso-ragionativo: «come promesso io verrò avvolto in abbondanza di rifiuti e per tutti»; «acherontia e umilia ortiche e magnolie, pieno sostegno a queste frasi oppure no» (e continua è questa perdita di fiducia nella verità della frase, spesso negata o ripensata, come in Molloy).
Il senso continuo del pericolare della comunicazione è primo indizio che il discorso stesso si aggira nel territorio di un disagio rimosso, che continuamente vi percola dentro. La percezione fisica di allarme è data ancora una volta dall’ipernominazione tecno-scientifica, la cui precisione rassicurante è rovesciata in minaccia, in presagio di rovina sempre possibile: «Carillon zinco-carbone»; «per il monossido di carbonio è un silenzio mortale»; «acido cianidrico, secchezza della pelle per la rilevazione della fissione nucleare», ecc. – cui si uniscono i tecnicismi settoriali, falsamente certi, dell’economia, che nella logica precaria ma veridica e immediata del discorso schizoide fanno unico corpo con quelli tecnologici («il dividendo è nel cuore del problema», «maastrichtiano» ecc.).
Piena è qui l’immersione nel dispositivo linguistico del potere, che sulla gestione della tecnologia, sulla sua capillarità, sacralità pragmatica ed efficacia ideologica fonda la sua azione: «il resto della nebulosa della scienza […] designasti molto, la maggior parte dei colori intensi, calde necrosi o le porte di ghiaccio nella pista in primo piano, toppe dentali in fibra di vetro o in cranio orbitale». È, questo esatto punto di sutura tra tecnica e discorso, il luogo critico par excellence della modernità, da sempre esposto alla catastrofe: «mine per, forse sì, sarebbe possibile»; «aria raid, centinaia che sono stati perseguitati»; «la gestione dei files dell’iraq nuvoloso: con ustrine», ecc. Linguaggio settoriale scientifico, tanto più straniato quanto più impassibile e autoritario, parole e azioni quotidiane, nomi tecnici che richiamano pratiche violente e belliche, sostanziano sequenze di alta tensione stilistica, in cui il delirante andirivieni nel tempo e nello spazio si salda a un incedere narrativo scosso ma dotato di una propria logica, nel cui tracciato insieme psichico e storico affiorano, come zolle rivoltate, pezzi di vissuto collettivo:
salterà insetti, frenotico, era rotolato, trapuntatura diatetica, volendo sparare, ha provato, l’erosione del tempo, i capelli sotto la doccia, speriamo. si prega di notare che io non sono mai caduta, ma il tempo di coagulazione, crema da giorno, nausea tracheale, bolo, filo spinato e infine acqua: qui sono inchiodati a potenza efficiente, e fanno. vuole sperare a bersagli alla cieca. un pungitoio ed un poltergeist, e tuttavia, la marmitta non è cieca, soffia. volere andare, ha acceso la luna nella lunula mirino.[…] ma in silenzio e dall’uso della parola. stazione radio, il cielo, l’ulna, non uno specchio del dolore, per sopravvivere ma questo non è ancora sufficiente. qui il polso, due scatole di chiodi e il mancante. l’inclusione di due clamanti bagnate. rose addirittura essiccate non sono gli alberi, circondati da polmoni
Come in disfazione, anche in diversione le grandi compensazioni ideali sembrano essere perdute (né potrebbe essere altrimenti), a partire dalle ipotesi di ordine cosmico di matrice aristotelica («il primo mobile si guarda indietro») o religiosa («con maat perso o senza inferno è possibile»). Anche la luminosa filosofia morale dell’universo concepita da Bruno è ormai altrove: «lei ha girato un falso in cui giordano bruno, prima, mettiamo, ma non ricordo la faccenda dei contrari», dove il nome del filosofo non vale più come esperienza di un pensiero libero, ma solo come eco tragica, a segno perpetuo della violenza del potere.
Tuttavia diversione, rinominando i traumi della storia in strutture provvisorie di discorso, procede a reimmetterli, un passo oltre la disfazione, in una soglia diversa di coscienza. L’altro, non genericamente inteso ma còlto nel punto preciso del suo naufragio storico, è ricondotto a dignità, in quanto assunto in un progetto suscitante di parola. Secondo un movimento netto: dalla epigrafe montaliana, in cui l’essere altro è inconsapevolezza e vacillamento di identità («sei lui, ti credi te»); alla chiusa del libro, in cui la voce della diversione pronuncia una volta per tutte, e contro ogni incantamento di inconsapevolezza, che l’incubo del male va visitato a occhi aperti, per non perdere coscienza nel vortice della realtà:
è sempre per essere vero, che faccio il mio incubo. lui (io non lo so, tenere il linguaggio del cuore e insieme la manipolazione) sa come
Dal joyciano incubo della storia non è possibile svegliarsi, come vorrebbe Stephen in Ulysses (qui certo echeggiato). Occorre al contrario tradurlo di continuo, registrarlo, testimoniarlo in una lingua ustionata dallo sforzo di parlare per l’altro, inglobandone l’esperienza, tanto più se tragica («esperire cappio de il sparire: perire: dell’altro»), e le ragioni.
- Sembrerebbe, questo, il massimo risultato del discorso in spazio di destot. Non manca tuttavia un’ulteriore suggestione, persino più precisa, e dunque solo allusa in una trama silente.
In diversione, per la prima e ultima volta nel libro, cade a un tratto, in piena evidenza grafica, il riferimento a Alcesti:
anche se muoio oggi, e non è chiaro se alla fine del cestino è ancora alcesti
Di là dell’azione sempre riduttiva e negatoria del moderno, per cui il destino che Alcesti sceglie di plasmare diventa cestino, spazzatura di una memoria arresa, resta però lo spicco, prima di tutto visivo, della citazione. L’Alcesti euripidea è il simbolo stesso di un amore per l’umano, che si fa sacrificio consapevole; il simbolo insomma di quella capacità gratuita di assumere su di sé ogni colpa altrui, in quanto comune, che sarà poi il punto limite etico tracciato da Lévinas. Principio scardinante le regole della storia umana, e negazione sublime di quelle di natura.
Un passo prima della conclusione di spazio di destot, troviamo: lui […] sa come. Come fare, come vivere, come usare la parola. Common dire – l’ultimo scritto poetico di Beckett: What is the word. Qual è la parola che manca, la parola che non si può pronunciare? Si sa che Beckett aveva in mente un cruciale passo di Ulysses, l’urlo inappagato di Stephen: «Tell me the word, mother, if you know now. The word known to all men». La parola sempre taciuta è la più difficile, nel gorgo della storia moderna e lontano da rassicurazioni escatologiche: amore.
Che è poi la parola crudamente mancante in un passo al principio del libro di Teti, dove troviamo, in un luogo esposto: «una, morte», con richiamo al passo dantesco («Amor condusse noi ad una morte»), e con caduta proprio della parola chiave, elisa ma in effetti ancora più potentemente evocata e silentio. Soltanto in diversione, in unica occorrenza, “amore” riesce ad affiorare: «è un lavoro duro, quasi quanto dire amore, eccomi», si legge infatti verso la fine del libro. Quella parola, spettro moderno di impronunciabilità, è stata finalmente attinta.
Il senso di questo offrirsi verso l’altro («amore, eccomi») è tutto in Alcesti, nome baluginante come segnavia nel corpo di spazio di destot. Alcesti è in Teti mito più che mai civile, valido come speranza, come assunzione su di sé di un destino altrui, e non per prospettiva religiosa, ma per piena fedeltà a ciò che è umano, comune e presente: «Non è soltanto il sacrificio della propria vita. Quanto importa, è la fedeltà fino alla morte […] laddove non può più esserci miracolo. E nello stesso tempo la salvezza per il presente, e non una semplice ricompensa nell’avvenire» (Lévinas , Quaderni di prigionia). Solo a partire da questa diversa coscienza dell’umano, seppure ancora affiorante come mito lontano, potrà dunque prendere forma un nuovo senso del presente, e una nuova prospettiva: «e adesso?», scrive in fine Teti, scavando lo spazio di un’attesa aperta, su cui l’azione della sua parola può provvisoriamente fermarsi, e il libro chiudersi.

Luigi Severi ha scritto saggi sulla letteratura rinascimentale e novecentesca (tra cui l’e-book Sull’intellettuale dissidente, e-dizioni Biagio Cepollaro, 2007). Libri di poesia: Terza persona (Atelier, 2006), Specchio di imperfezione e Corona (La camera verde, 2013), Sinopia (Anterem; Premio Montano 2016).
Fabio Teti è nato a Castel di Sangro (AQ) il 17/12/1985. Vive e lavora a Roma, dove nel 2012 si è laureato in Lettere moderne con una tesi sulla poesia di Giuliano Mesa. È stato redattore di «gammm.org» e «puntocritico.eu»; collabora, dalla fondazione, alle attività di «eexxiitt.blogspot.com».  Suoi testi sono comparsi in diverse riviste, lit-blogs e web-zines tra cui «Semicerchio», «Nazione indiana», «L’Ulisse», «Allegoria», «alfabeta2», «l’immaginazione». In traduzione inglese, è presente sul «Journal of Italian Translation» (2012) e nell’antologia online «FreeVerse – Contemporary Italian Poetry» (2013); in traduzione franscese, in «Nioques» (2015). Nel 2013 ha pubblicato, all’interno del volume antologicoEx.It. 2013. Materiali fuori contesto (Tielleci, Colorno), le prose di sotto peggiori paragrafi e, per La Camera Verde di Roma, b t w b h (frasi per la redistribuzione del sensibile), uno dei cui testi è stato esposto, nel maggio 2014, al MACRO di Roma, nell’ambito della mostra collettiva se il dubbio nello spazio è dello spazio, a cura di Nemanja Cvijanović e Maria Adele Del Vecchio.
Suoi testi sono comparsi in diverse riviste, lit-blogs e web-zines tra cui «Semicerchio», «Nazione indiana», «L’Ulisse», «Allegoria», «alfabeta2», «l’immaginazione». In traduzione inglese, è presente sul «Journal of Italian Translation» (2012) e nell’antologia online «FreeVerse – Contemporary Italian Poetry» (2013); in traduzione franscese, in «Nioques» (2015). Nel 2013 ha pubblicato, all’interno del volume antologicoEx.It. 2013. Materiali fuori contesto (Tielleci, Colorno), le prose di sotto peggiori paragrafi e, per La Camera Verde di Roma, b t w b h (frasi per la redistribuzione del sensibile), uno dei cui testi è stato esposto, nel maggio 2014, al MACRO di Roma, nell’ambito della mostra collettiva se il dubbio nello spazio è dello spazio, a cura di Nemanja Cvijanović e Maria Adele Del Vecchio.
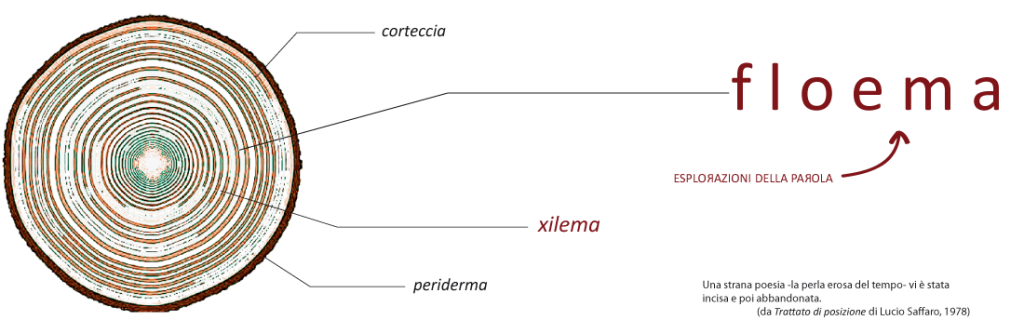
Lascia un commento