MARCO GIOVENALE
scritture di ricerca, prima e dopo il paradigma
La video intervista si è tenuta a Firenze il 21 novembre 2013, in occasione della presentazione del libro “Delvaux” (Oèdipus edizioni) di Marco Giovenale ed è focalizzata sul concetto di “scrittura di ricerca” e “scrittura post-paradigmatica”. Si tratta di un’intervista quasi estemporanea tale che Marco, considerata la densità delle domande, ha deciso qualche mese più tardi di regalarci un approfondimento scritto a quanto era già stato accennato a Firenze.
COLLOQUIALE N°6/a
a cura di Daniele Poletti
1) Partiamo da una considerazione terminologica che, seppure già scandagliata in lungo e in largo negli anni e dalla critica, può essere giovevole per affrontare il tema della “scrittura di ricerca”. Declinando la riflessione secondo la teoria degli insiemi: descrivici brevemente le parole “avanguardia”, “sperimentale”, “ricerca”, per cercare di capire quanto sono tangenti alle nuove scritture.
L’idea stessa di una descrizione come delimitazione di aree, di insiemi, è in effetti rischiosa, temo, o fuori campo, a mio avviso, anche perché (e ciò sia detto anche a critica degli artisti e autori stessi e delle definizioni che impiegano) l’area o campo non è tale, non è cioè un campo, già in termini di percezione e di attribuzione di senso alla percezione. E le cose sembrerebbero stare così almeno dalla fine del Settecento, all’apparire della terza Critica kantiana. L’insieme degli oggetti portatori di senso-non-senso non è in effetti un insieme (semmai un motore di paradossi, come quello della sua identità o meglio natura).
La nascita stessa della fotografia lo dimostra. (Prima, e più ancora, lo dimostra la mutazione degli statuti percettivi generali dell’osservatore: cfr. J. Crary, Le tecniche dell’osservatore, MIT 1990, trad. it. Einaudi 2013). Il campo o riquadro si smargina, fa molta fatica a tenere fermi gli oggetti. Sfuggono. Non si sa quale esattamente debba esserne (o finir per esserne) l’identità. Detto ciò, ovviamente ci si industria con quegli inevitabili salti e tagli e cicatrici mal cucite nel non-tessuto della materia linguistica che chiamiamo definizioni. Arrangiandoci dunque con queste, e tenendo ben presente che spesso originano o complicano più questioni di quante ne risolvano, proviamo a misurarci con alcune.
Se di avanguardia parliamo in senso militare, militante, è molto dubbio che possa non essere definito d’avanguardia pure il più entusiasta dei reazionari petrarcaici mainstream, che sostanzialmente – lancia in resta – non mira a molto altro che al successo personale e/o alla attestazione di una sua linea connotante (identitaria, non testuale), o catena distributiva, editoriale, libraria, commerciale, prima ancora che letteraria. Se però – chiudendo per un istante la porta ai riferimenti extraletterari e ragionando di e su fatti e temi di scrittura – stiamo a una parte della storia letteraria italiana ancora in grado di incidere su correnti e atteggiamenti, dobbiamo registrare accezioni che hanno avuto significato e forse ne hanno. Fosse pure un significato contrastivo.
Dunque, barrata la militanza intesa in senso extraletterario, abbiamo esempi storicizzati che ci dicono cose non troppo imprecise sull’avanguardia. In particolare, tanto per le prime avanguardie che per le successive, il discorso su centralità di linguaggio e metalinguaggio è noto, e difficilmente aggirabile. Così come un piglio – talvolta un cipiglio – politico, pure.
Sperimentale, poi, è molta scrittura anche non novecentesca. Chiaramente l’uso che dell’aggettivo si fa – nel Novecento e dopo – ha a che fare giocoforza con una postura iper-riflessa, aperta se non spregiudicata nei confronti del linguaggio ereditato, delle lingue europee, e con un dialogo meno vincolante con la tradizione: «ciò non significa che il poeta ha fatto tabula rasa della tradizione: è il lettore timorato che ha il torto di connettere la tradizione con l’idea del dovere» (Giuliani nella prefazione 1965 ai Novissimi). Tuttavia, di un’accezione ancora diversa di sperimentalismo si sono pur fatti vettori i testi e le voci di autori che di un radicamento nella tradizione italiana, non esente da un peculiare plurilinguismo, facevano un caposaldo: e anche qui nulla di nuovo sotto il sole, se i nomi di Pasolini o Roversi (meglio se dagli anni Sessanta) possono esser ripetuti, e quelli – p.es. – di Pagliarani e Leonetti funzionare, in parallelo, da cerniera fra questa accezione di sperimentalismo e le coeve accezioni di avanguardia, come è a tutti ben noto, anche qui, e ampiamente storicizzato.
Posso sbagliare, ma mi sembra poi che di “scrittura di ricerca” si parli da assai più tempo di quanto afferma qualche pretestuosa noiosa polemica (in rete o fuori). Da prima di quel 2003 annus mirabilis dell’avvento massiccio della Rete nelle lettere (italiane). Ovviamente, dopo, avendo reso l’espressione “scrittura di ricerca” una specie di refrain o tag, ed essendo giocoforza questo entrato nel macromicromondo del detto web, la conseguenza è stata ed è una maggiore visibilità della (non)definizione, e con ciò l’impazzare dei tormentoni e l’impazzire della maionese di tutti coloro (me incluso) che presumono di avere da dire, sul tema, qualcosa di non contingente.
Nonostante ciò, pare che “scrittura di ricerca” riscuota successo soprattutto presso i suoi detrattori e mislettori, e presso tutti quegli scrittori che si dichiarano insoddisfatti e non pienamente descritti dalla definizione. Singolare destino, a cui penso sarebbe puerile da parte mia presumere di dare una svolta o spin di qualche momento, in poche righe, o in molte.
Aggiungo solo una notilla estrema: se – in quell’insiemistica di cui in incipit dubitavo – si incrociano “avanguardia” e “ricerca”, più che spazi geometrici vediamo profilarsi magari un atteggiamento. Un atteggiamento di incertezza e indefinizione per la seconda, rispetto a talune certezze della prima. E vediamo anche comporsi il profilo di una mancanza, in Italia, collocabile tra metà anni Ottanta e fine anni Novanta: un mancato o minimo distacco dalle linee e dai laboratori linguistici e metalinguistici degli anni Sessanta, che è invece avvenuto ed ha avuto effetti nelle zone anglofona e (soprattutto) francofona. Fuori d’Italia un distacco nella continuità non solo si è avuto ma è stato di segno particolarmente forte. In Italia ha subìto quasi sempre e quasi ovunque un ritardo. Limite che pare – post quem – latamente sovrapponibile al buio politico degli stessi anni. (So bene che gli autori non c’entrano, col buio, ma col distacco mancante o parziale – in letteratura – forse sì).
2) Scrittura prima e dopo il “paradigma”. Dal tentativo di proposta e sistematizzazione di “un cambio di paradigma”, sembra si sia passati all’affermazione di una scrittura post-paradigmatica come nuovo paradigma: quali sono i presupposti sociali, civili e politici per poter affermare questo? Non c’è forse il rischio di voler imporre una nuova ortodossia?
Se volessi affilare una critica (che qui non vedo né credo pertinente, dato il contesto amichevole), direi che semmai è singolare che al primo albeggiare, nella nebbia, si indossino in fretta gli occhiali da sole. Nemmeno ancora ‘sappiamo’ (sempre che sia qualcosa da ‘sapere’) di cosa parliamo quando parliamo di post-paradigma, nemmeno è stata tradotta una centesima parte degli autori che in tutto il mondo scrivono ‘così’, e già si attiva l’allarme ortodossia. Questo, semmai, mi allarmerebbe.
Dico ciò senza ancora aggiungere che un mutamento di paradigma non è un mutamento di stili, di retoriche (o che insomma non è soltanto questo) ma coinvolge la stessa idea di ortodossia, mettendola in questione.
Se il paradigma muta, è proprio in stretto legame con la non percettibilità attestata (né riattestabile) di qualcosa come una ortodossia. Se la scrittura è di ricerca, è proprio perché davvero e strutturalmente non sa, non può sapere compiutamente, cosa va cercando; o non può saperlo riarretrando con lo sguardo – dopo lo scritto – solo sullo scritto stesso, formalizzando leggi o ricorrenze verificabili in toto sul tessuto dato. (Essendo non più tout court “tessuto” l’oggetto osservabile). E come può allora cristallizzare delle regole, delle forme di ortodossia? Ne sarebbe semmai la negazione, se non fosse che perfino un atteggiamento duale (ortodossia vs non-ortodossia) rischia di esser qualcosa di improponibile, rigido, perfino premoderno.
Addendum: come posso dire che lo sguardo non riarretra sullo scritto? Non è, lo scritto, tutto ciò che va indagato? Cosa altro osservare? Non certo l’intentio auctoris, le tecniche usate, le fole di poetica, l’editore che stampa, eccetera. Chiaro. Ma aggiungo: l’osservazione corra non solo al mero ‘tessuto’ registrabile (sillabe, lessico, sintassi, architettura, …) della pagina, ma – importante – al tipo di sguardo e specchio proprio e altrui che l’autore (grazie al tessuto che la pagina di fatto certo espone) implica / genera / contratta / co-struttura / determina / sottintende nell’opera. Ma di questo più avanti. (Al punto 5).
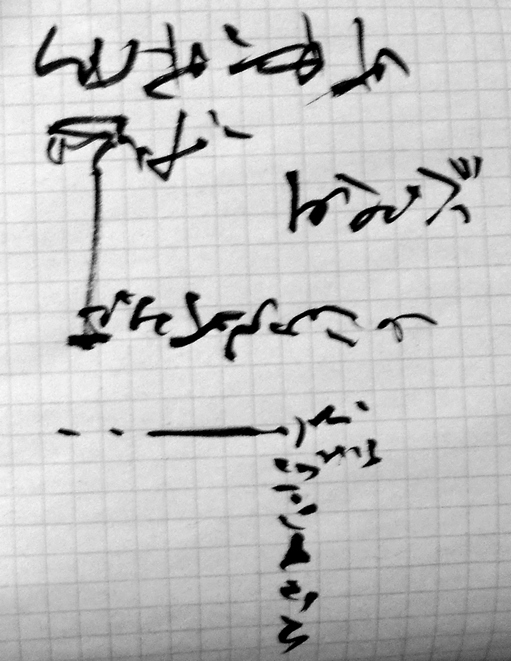
3) Il gruppo 93 e il post-modernismo critico vengono citati raramente quando si raffrontano le nuove scritture con il recente passato e quasi sempre il riferimento è il gruppo 63. A tuo avviso quanto il gruppo 93 ha inciso sul cambio di direzione della “scrittura sperimentale” e quanto ha preconizzato l’oggi della scrittura?
Ex abrupto la tentazione sarebbe quella di dire che quando (e non a caso in quel momento) alcuni autori del gruppo hanno chiuso la porta “93” e radicalmente ripensato alcune scelte stilistiche (o meglio: smesso di pensare “per stile”), si sono accostati a qualcosa di indefinibile e più vicino a un mutamento e movimento che fuori d’Italia era nell’aria e nell’epoca. Penso al Baino di Pinocchio (moviole) o Le anatre di ghiaccio. O a certe cose recenti di Cepollaro. Altri autori sviluppavano un discorso, nuovamente/diversamente ‘modernista’, di grande energia testuale (penso a Giuliano Mesa, che per tanti aspetti potrebbe esser letto come autore tutt’altro che lontano dal percorso, ad esempio, di Rachel Blau DuPlessis). C’erano poi personalità a mio avviso connotate da un’indipendenza/isolamento e da una ‘volontà di struttura’ assolutamente peculiari, come Frixione, per le quali è impossibile non parlare di ricerca, e allo stesso tempo è impossibile non vedere la pertinenza a un tipo di scritture legate a (vincolate da) doppio filo al ruolo delle contraintes linguistiche.
Riflettendo meglio, va pur sottolineato che negli anni Novanta si deve principalmente a quel gruppo di autori, e in particolare alla rivista «Baldus», un’apertura a spazi non italiani di ricerca: cfr. in particolare il n. 2 del 1992 e tutti e tre i numeri usciti (non casualmente) nel 1995.
4) Le nuove scritture e la complessità. C’è ancora spazio nella scrittura post-paradigmatica per una complessità semantica e sintattica, considerato che lo stile della prosa in prosa o della post-poésie è quasi sempre orizzontale, privo di abbellimenti analogico-metaforici del reale, a pura denotazione fattuale?
Difficile rispondere. Chi può dirlo? Tutte le scritture di ricerca fanno problema nel momento in cui tentano di fissare punti programmatici netti. La domanda mi dà modo di precisare e ripetere anche, a proposito delle mie tante liste e tracce di ‘placet’/‘non placet’ sparse in rete, che i gusti e le direzioni individuali si misurano sempre alla prova del fuoco testuale. Non è in nessun modo possibile né lecito – è semmai ben assurdo – dare qualcosa come delle ‘direzioni’. Forse nemmeno minime indicazioni personali, unica tentazione a cui posso aver ceduto. (Sono però comunque non sempre opportuni i testi critici miei che così si muovono o sembrano muoversi; è vero però che spesso i lettori ne prendono solo i segmenti asseveranti, e non considerano le attenuazioni, le perifrasi limitative, le parentesi di dubbio, che invece sono essenziali).
Mi rendo conto che questa messa in mora di ogni definizione, più che essere un sano modus operandi fenomenologico, rischia di rivelarsi banale vaghezza. L’indeterminazione non è indeterminatezza, ma forse corre costantemente il rischio di esserlo.
Tornando alla domanda, mi sento di aggiungere che “complessità semantica e sintattica” è una cosa, e complicazione (soprattutto lessicale) un’altra. Quest’ultima, in particolare, mi pare ‘consumata’. Non che non possa funzionare, chiaro. Ma se n’è vista tanta, ma tanta, nell’area degli epigonismi laborintici, anche in autori di valore.
Tanto cattivo surrealismo ha, pure, fatto il suo tempo, a mio modo di vedere. Idem gli estenuati iper-consci e iper-esibiti etimologismi (trait d’union, questo della passione etimologica, che lega in strane nozze l’avant-guardrail più ammaccato ai lirici petrarcaici innamorati degli isosillabismi in cui possono incastrare e far dire qualcosa di apparentemente profondo a neoformazioni immaginose, mattoncini denominali, deverbali, relitti di latinorum).
Lo scriver complesso è ben accetto quanto il suo contrario, dunque. Certo, esiste una storia (e stanchezze variamente articolate) nella vicenda e nell’uso dell’uno come dell’altro.
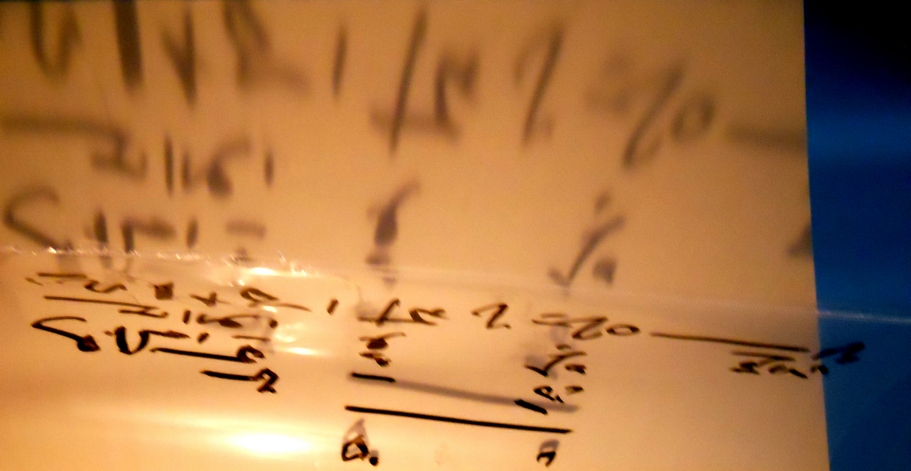
5) Scrittura assertiva e anassertiva. Quali sono le esigenze interiori, estetiche e concettuali che determinano questo tipo di scrittura? È una scrittura programmatica, dimostrativa di un nuovo modo che soppianta pesantemente il passato?
Sulla seconda domanda rinvierei a quanto detto replicando al punto 2, poco sopra. Sulla prima domanda mi diffondo (più) volentieri, come posso. Non è improprio né ingenuo parlare di esigenze interiori, in primis. L’asserzione (nella possibile accezione di: scrittura che preorienta imperiosamente la reazione del lettore) a mio avviso risponde a un’esigenza interiore che talvolta può configurarsi come divisa tra il narcisismo autoriale e la sfiducia dell’auctor medesimo nelle capacità ermeneutiche del lettore. Al contrario, un’opera non assertiva può essere la traccia di una deviazione dello sguardo dalla figura autoriale come riferimento orientante, di spicco, e allo stesso tempo il segno di una estrema apertura verso le capacità di indagine (e costruzione di realtà) dell’altro. Mi è capitato di dire più di una volta che questo configura premesse e prefigura conseguenze di natura perfino ‘politica’, in senso ampio.
Le esigenze concettuali o “estetiche”, poi, sono forse ancora un campo indefinito. Dar loro definizione rischia di aderire a una sorta di assertività di poetica, tentazione o direzione impropria (a mio avviso, e per quel che mi riguarda). (Ne parlavo or ora, rispondendo al punto 4).
[Apro una lunghissima parentesi quadra.
Torno non brevemente sull’espressione “scrittura assertiva”, perché ho l’impressione che generi spesso (motivata) confusione. Un’accezione che mi sentirei di dare è quella tratteggiata poco sopra: scrittura che preorienta imperiosamente la reazione del lettore. Oppure: scrittura che proietta sulla distanza fra autore e lettore non solo dei parametri di decodifica=ricodifica tagliati sulle misure autoriali, ma altresì i fantasmi di una specie di feedback di consenso, anch’esso vicino a poter esser definito preorientato. (E: come dato per scontato).
Senza neanche troppa malizia si domanderà: quale scrittura non opera così? Quale pagina non preorienta reazioni, e non si struttura secondo alcune caratteristiche della mano che scrive e di sue implicite richieste di feedback? In verità, proprio nelle faglie sottili tra queste e dentro queste domande entrano le lamelle necessarie del dubbio, quando ad essere in campo è una certa scrittura di ricerca. (Scrittura dell’incerto, di ombre? Forse. Scrittura di quello che ancora non si sa, non si vede). (E come si può chiedere consenso sul non noto, sul non interamente o sul niente affatto noto?).
Di sottigliezza e di crepe si può parlare non nel mero senso di dimensioni sfuggenti, minime, ma di una inafferrabilità più complessa ancora, che disarticola e riarticola quelle domande, ed è volentieri connessa ai pochi gradi di spostamento (orientamento) di una e più superfici specchianti che magnificano e assai moltiplicano l’angolatura dello sguardo.
Mi spiego.
Il fatto è che chiunque di noi – sempre – parlando costituisce, a prescindere da posizioni autoriali, una sorta di microlabirinto di specchi, orientati in parte verso la lingua stessa, in parte verso un ‘narrato’ (diciamo genericamente), in parte verso un’asserzione legata all’ombra allegorica del narrato, in parte verso l’autore in sé, in parte verso chi ascolta (e, cosa nodale, verso le sue aspettative).
Ognuno – ciascuno di questi orientamenti – cambia non solo il labirinto generale, ma il proprio rapporto con tutti i dettagli e le reazioni degli orientamenti accanto. Ebbene. Quanto più gli specchi qui nominati, coi loro clic e millimetri, introducono nello specchiare anche un’intenzione di ‘indirizzamento’ (preorientamento) codificato dello sguardo altrui, tanto più affermano, asseriscono, segnano a dito il rameggio delle linee di senso, implicano microspostamenti nell’altrui ricezione ed elaborazione del senso. Lasciando purtroppo indietro, in questo modo, tutto ciò che esse stesse (linee) ed essi stessi (specchi) non sanno di verbalizzare, formare, formulare, visualizzare, riflettere.
In asserzione, i gradi differenziali delle loro inclinazioni contano, in termini di ricerca, assai meno del profilarsi dello sguardo di cui chiedono l’assenso. Il labirinto allora si costella di indicazioni: “uscita”, “entrata”, “vicolo cieco”, e smette di conoscere, di far conoscere. Diventa una macchina per eseguire un itinerario, un tour. Per dire e sentirsi dire come muoversi, venir rassicurati sulla direzione. (“Sto andando bene?”. “Mi riconosci?”. “Hai ben capito di quale emozione sto dando immagine?”. “Arriva il messaggio?”. “Arriva l’immagine?”. “Si prende il segnale? È abbastanza nitido?”. “Sono io, vedi?”. “Qui sei tu, vedi?”).
(Bon. Le mie domande allora sono: di questo si ha bisogno? Di queste moine? Di testi che non fanno che rivolgere al lettore un occhiolino di frase, un amo, un gancio, un “guardami”?).
Così – p.es. – un verbo imperfetto perfettamente memoriale, senza traccia di ironia, né di sfaldamento delle proprie certezze temporali, tante volte è asserzione non perché faccia “elegia”, o “autonarrazione” o abbia una qualche velatura nostalgica anche astratta, ma perché afferma una certezza di tenuta e riflesso/condivisione del senso (di avvertite tenuta e pertinenza dei segnali indicatori all’interno del labirinto) che pretende integrità di percezione, stabilità e valore, da subito, e addirittura prima, ancora prima, di essere qualsiasi cosa, sia elegia o narrazione. Ha già piegato il proprio sistema di specchi in un certo modo, accattivandosi e misurando i gesti di lettura e (ri)costruzione del senso di chi osserva.
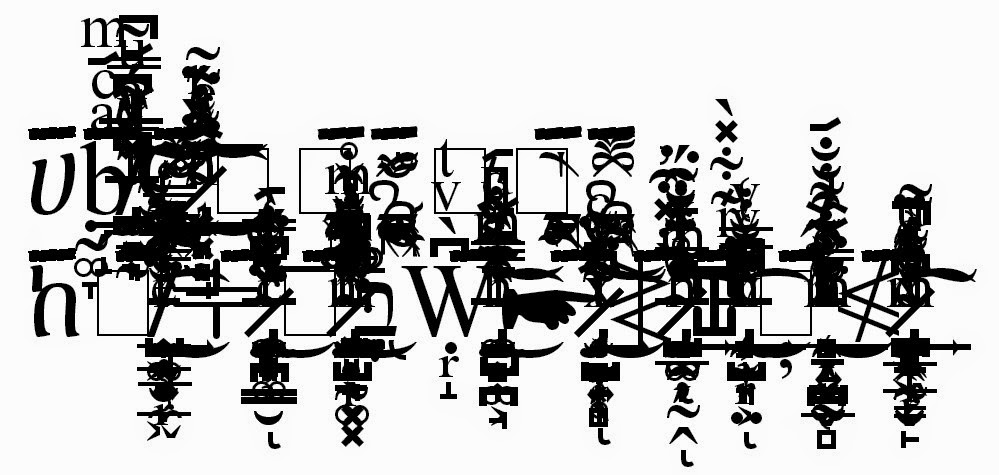
Ogni comunicazione fra umani si regge su un patto di incontro. Solitamente ci si trova a metà strada. Qualche volta la strada che l’autore deve chiedere al lettore di compiere è più lunga rispetto a quella che l’autore stesso fa verso il lettore. Talvolta è invece più breve. Bon. Un elemento che forse distingue la scrittura di ricerca dalle altre è che nel suo ambito, quale che sia il tratto da percorrere, l’autore non va incontro al lettore con un contratto di leggibilità prefirmato (presuntivamente dal lettore stesso!). A volte discute il contratto in itinere con lui. In altri casi, neanche lui si raccapezza sui parametri di leggibilità e scioglimento, e dunque non ha proprio nessun contratto da proporre. And so on.
Ma mi fermo.
Forse la miglior definizione di scrittura non assertiva non è data dal pulviscolo teorico, dalla complessità delle (tentate) approssimazioni. Può semmai esser trovata nei testi stessi, che tuttavia paiono singolarmente allontanati dalle sedi di interlocuzione. (Non questa, è più che ovvio). Trovo evidente giudicare non assertiva la serie di Christophe Fiat, Un’avventura di Batman a Gotham City, per esempio. (La prima uscita su gammm è qui: http://gammm.org/index.php/2008/03/01/une-aventure-de-batman-a-gotham-city-prima-puntata-christophe-fiat-1999-2004/; ne sono seguite altre due). O Reader’s Block di David Markson (http://gammm.org/index.php/2007/07/13/reader-s-block-david-markson/). Due citazioni fra moltissime, queste appena fatte, per non tornare agli esempi su cui forse troppo ossessivamente insisto: Christophe Tarkos e Corrado Costa soprattutto. Siamo d’accordo? Ci intendiamo sulla non assertività di queste scritture? Sottolineo: sono loro, sempre, a precedere la teoria. Se, in tema, si troverà che io ho detto fin qui imprecisioni, e chiedo venia, non è (solo) perché non sono stato capace di giungere a un buon grado di sintesi teorica, ma soprattutto perché le scritture di Tarkos e degli altri mettono felicemente in scacco ogni (mia) teoria. Fatto, questo, vitalissimo e positivo.
Chiudo la parentesi quadra].
6) La molteplicità del reale è un grande cut-up (come scrive Burroughs in La scrittura creativa: http://gammm.org/index.php/2012/12/20/vuol-dire-quello-che-vedete-effettivamente-william-burroughs/), ma per rendere concreta questa molteplicità in una realtà scritturale, bisogna per forza dimenticarsi che il reale è anche costituito da strutture rappresentative colte, da stratificazioni della lingua e dei significati, da gerghi tecnici e di settore? (E il pastiche che comunque è aumentato esponenzialmente, babelicamente, proprio grazie all’avvento delle nuove tecnologie….).
Tutto può, a mio avviso, essere fatto e disfatto. Il problema delle strutture colte, delle stratificazioni linguistiche, a differenza p.es. di molta ‘bruta’ e magari brutta oggettualità, è che funzionano meno innaturalmente di quest’ultima ad agganciare l’ego autoriale, e a tenerlo stretto a un’autorappresentazione effettivamente, proprio fattivamente a rischio di narcisismi. Gerghi tecnici, e loro derivazioni/elaborazioni complesse, luoghi linguistici ‘forbiti’, golosi, sono il paradiso dell’esibizione, dello spettacolo. (Questo senza togliere ed escludere che può esistere un esibizionismo della secchezza, della ritenzione verbale, dell’“oggettualità’, certo).
7) Tu non sei uno scrittore totalmente “dopo il paradigma”, convivono nella tua produzione diversi casi, ma abbastanza distinti l’uno dall’altro. Da dove parte e fin dove arriva la contaminazione?
Ogni testo forse potrebbere rispondere in modo proprio, peculiare: da quelli in cui la compresenza (come integrazione e/o contrasto) è più forte, a quelli in cui tale compresenza non è minimamente riscontrabile, o lo è in modo limitato. Tra i testi ‘di compresenza’ vanno ovviamente elencati La casa esposta, Shelter, In rebus. Tra quelli più ‘granitici’ direi Il segno meno, Delvaux e forse Soluzione della materia come esempi di rielaborazione di Novecento, di modernismo; e – sul fronte opposto – Quasi tutti o A gunless tea, CDK e l’imminente Anachromisms come esempi di ‘passaggio di paradigma’, mutazione più radicale.
Ovvio che a ognuna di queste opere non si possa assegnare un’etichetta unica, che ne esaurisca una qualche pertinenza reale a categorie. (Essendo, tutte le categorie, costruzioni ben poco ‘raffinate’, lo ripeto e lo ammetto, lo sappiamo). Andranno dunque anche prese con una variabile quantità di libertà e scetticismo.
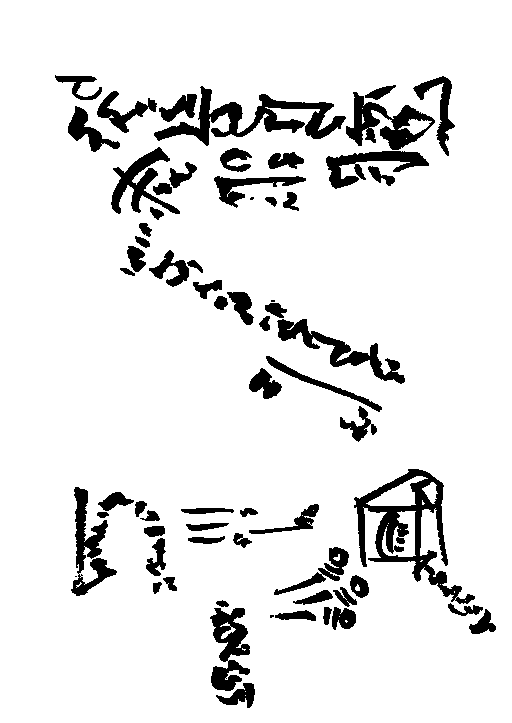
8) In un tuo articolo su slowforward hai scritto: “Solo chi si ostina a non leggere (e soprattutto a non considerare le valanghe di scritture nuove che vengono da paesi non italofoni) può sostenere serenamente che non esiste una novità radicale, o meglio una diversità profonda (e non riportabile a meri connotati linguistici e formali) tra materiali prima e dopo il paradigma”. Qual è nello specifico questa diversità profonda?
Se non è riportabile a meri connotati linguistici e formali, come posso delimitarla, rigorosamente, col e nel linguaggio di cui già disponiamo? Non sarà da indagare, ancora? Come darle una descrittibilità in termini di forme (condivise)? Di nuovo: cosa unisce autori come Corrado Costa e Christophe Tarkos? Una wittgensteiniana ‘aria di famiglia’? Forse. In gran parte inafferrabile. (E inafferrata, senza letture degli stessi, e di altri, molti altri).
Davvero la lettura e il confronto sono indispensabili. Vero è che ormai si può constatare che scritture ‘dopo il paradigma’ si trovano in gran numero anche in italiano. Non è per forza a una costellazione francese o inglese che ci si deve riferire per avere anche solo un’idea di contesto, stili, materiali, come invece era in pratica inevitabile fino a qualche anno fa. Nell’arco di meno di dieci anni sono uscite forse più di tre dozzine di libri che possono dare un quadro della situazione…
Marco Giovenale vive a Roma dove lavora come editor e traduttore indipendente. È tra i fondatori di gammm.org (2006), e  puntocritico.eu, eexxiitt, asemic-net (tutti del 2011). È redattore di varie riviste cartacee e spazi web, tra cui sibila.com.br. Collabora con «l’immaginazione» e «alfabeta2». Cura la collana Logosfere per l’editrice Zona, Syn per le edizioni IkonaLíber, e la collana Benway Series (per l’editore Tielleci) con M. Guatteri, M. Zaffarano e G. Marzaioli.
puntocritico.eu, eexxiitt, asemic-net (tutti del 2011). È redattore di varie riviste cartacee e spazi web, tra cui sibila.com.br. Collabora con «l’immaginazione» e «alfabeta2». Cura la collana Logosfere per l’editrice Zona, Syn per le edizioni IkonaLíber, e la collana Benway Series (per l’editore Tielleci) con M. Guatteri, M. Zaffarano e G. Marzaioli.
I suoi libri di poesia più recenti sono Shelter (Donzelli, 2010), Storia dei minuti (Transeuropa, 2010), In rebus (Zona, 2012, con i testi vincitori del premio Antonio Delfini 2009), Delvaux (Oèdipus, 2013). In uscita: Maniera nera (2015). Tra le prose: Numeri primi (Arcipelago, 2006), Quasi tutti (Polìmata, 2010) e Lie lie (La camera verde, 2010).
Suoi testi sono antologizzati, fra altre sedi, in Parola plurale (Sossella, 2005), Nono quaderno di poesia contemporanea (Marcos y Marcos, 2007), nel volume del Premio Antonio Delfini 2009, in Poesia degli anni Zero (Ponte Sisto, 2011) e in Nuovi oggettivisti (Loffredo, 2013). Altre rassegne antologiche che lo includono (non italiane) sono in uscita nel 2015.
Con i redattori di gammm è nel libro collettivo Prosa in prosa (Le Lettere, 2009).
È autore di alcuni testi in inglese: A gunless tea (Dusie, 2007), CDK (Tir Aux Pigeons, 2009), anachromisms (Ahsahta Press, 2014) e white while (Gauss PDF, 2014). Una bibliografia e otto ossidiane inedite sono in Tagli/tmesi (La camera verde, 2013).
Per Sossella nel 2008 ha curato una ampia raccolta antologica di testi di Roberto Roversi. Nel 2014 ha tradotto, per La camera verde, Billy the Kid, di Jack Spicer.
Il suo blog è slowforward.wordpress.com
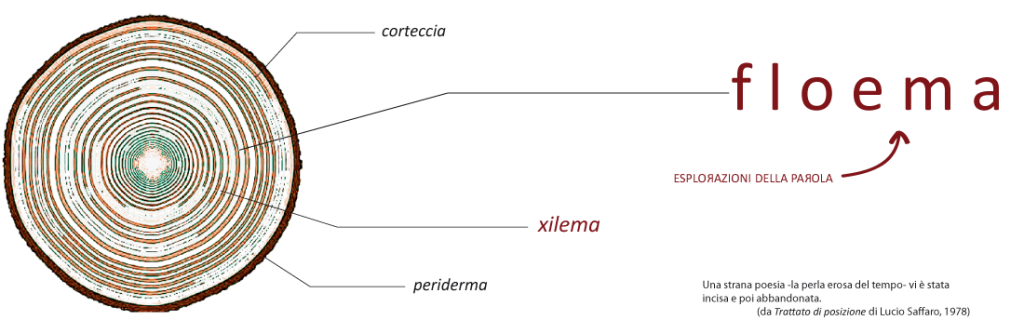
Lascia un commento