
Pubblichiamo un testo molto partecipato di Gisella Vismara (critico d’arte e docente presso l’Accademia di Brera) sul mondo poetico di Domenico Brancale. Ringraziamo l’autore per averci concesso la riproduzione di undici poesie tratte da “Incerti umani” (Passigli, 2013) e l’Archivio Giacinto Cerone per le immagini che accompagnano questo articolo.
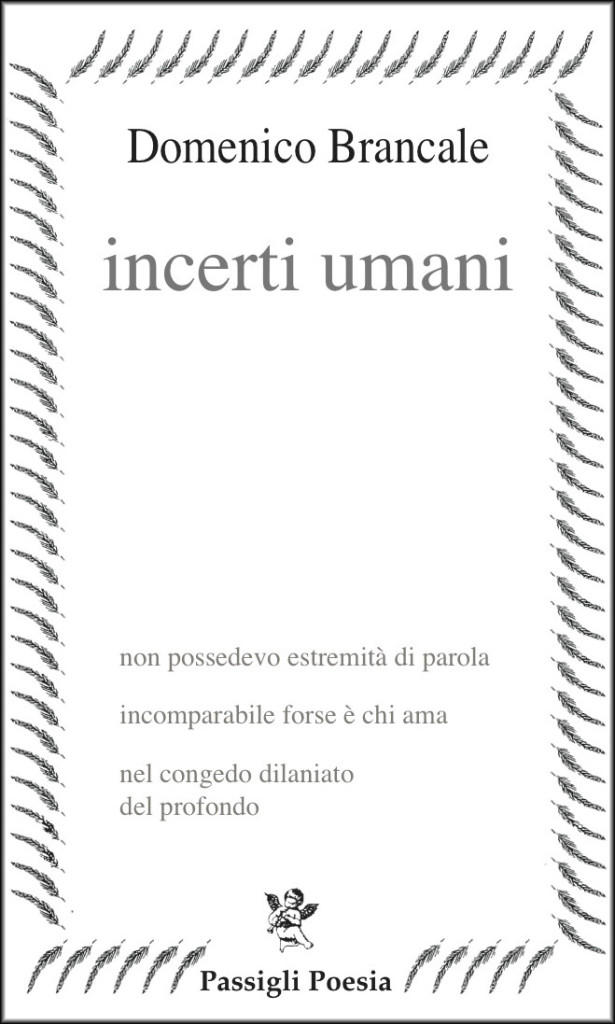
La poesia di Brancale può essere collocata di diritto nella tradizione più aulica della scrittura novecentesca, dove attraverso il canto si ordinano l’evocazione, la suggestione che nascono dal sentire profondo, in questo caso un sentire doloroso. Nessuna connessione con i funambolismi sperimentali o con la “poesia oggettiva”; ci troviamo di fronte alla verticalizzazione della percezione attraverso rapporti metaforici e analogici piuttosto marcati, che denunciano una scrittura molto sorvegliata e di regìa. Si tratta certo di un canto spezzato da un fiato che si attesta spesso nella cadenza endecasillabica, ma che anche vi si affranca con parole enucleate, “parole/verso” e organizzazione dei bianchi. Crediamo di intravedere nella scrittura di Brancale la lezione delle prime prove celaniane, dove il meccanismo relazionale è conchiuso tra “tu”, “io” e “chi”, creando un mondo stretto e appartato, con meccaniche, rituali e figurazioni spesso idiolettiche, inscindibilmente legate all’esperienza e alla presenza corporea, nell’intento di diventare allegoriche. Pertinente, ci sembra, il langsam dei trio e quartetti di Anton Webern.
Un ultimo accenno va riservato alla compattezza (almeno in questo “Incerti umani”) dei campi semantici e delle scelte lessicali che creano una tassonomia precisa dell’incertitudine e della fluttuazione del corpo nel mondo dei fatti. Le parole e il loro rincorrersi semantico hanno un’ aderenza fortissima con le stanze dell’assenza e del lutto, dove per lutto si debba intendere anche e soprattutto “separazione” e morte in vita. Pensiamo comunque che dietro questo nichilismo, determinato da un dolore (quanto condiviso e condivisibile?) esistenziale più che esistentivo, vi sia la concezione di un corpo naturale che si disfa e rinasce: come se fosse tronco spaccato/la lingua che germoglia/dove l’acqua in risalita si arresta. (Daniele Poletti)
*
il vuoto del corpo blindato a quattro mandate
non apre al tempo
lontano da chiavi
serrato è dentro
sussurrartelo, avrei dovuto tacerlo
chi di noi è l’aperto
chi l’aperto senza contrari rimedi
senza serrami
e continui a lasciarmi unto
a fare ciechi gli istanti presso il labbro parlante
inviolabile solo
come sono vicino all’evanescenza
al tu intimato senso
da tutto
da noi
da niente
… ci sono ancora chiavistelli da spezzare
Il padre morto
di Gisella Vismara
“E se vale la pena rischiare,
io mi gioco anche l’ultimo frammento di cuore”.
(Ernesto Che Guevara )
Un giorno una giovane figlia sussurrò l’eterno riposo ad un poeta nato per vivere nella condanna di essere padre; sangue del suo sangue, quel padre, irrevocabilmente, le pareva morto.
L’inconsapevole verità dell’innocenza, vergine come la morte, ricorda da vicino ciò che accade nei giochi di parole e nei discorsi dei “folli”, in cui certo sano giudizio sull’esistere penetra senza pietà il ventre dell’altro fino a sbrindellarlo.
“Il poeta non dorme mai ma in compenso muore spesso”, avrebbe spiegato Alda Merini; poetessa, reietta e ultima tra gli ultimi, che, salvata dalla parola, ha riscattato l’umiliazione del recluso e la sua condanna dell’essere morta tra i vivi. Con la sua mano di malata tra i “sani”, anch’essa, come Brancale, ha scritto le sorti dello stato incerto dell’essere, in quel precipizio in cui l’Umanità al margine urla il diritto all’immortalità rivendicandolo fino a perderne la voce; grido come eco perpetuo e straziato che può provenire solo da certe stanze, le quali “rimbombano sempre” poiché – si dice – “siano tra le più vuote al mondo”1.
È la condizione in cui l’umano sgolato si mostra in gabbia, nella sua presenza autentica, nel dolore, nella sofferenza del confino di un Io incatenato alla terra che riesce a convivere, in eterno, odiando il proprio corpo traditore. Il muro, la cella, il manicomio, e le loro tracce perpetue sull’uomo, rappresentano condizioni estreme di vita, dove il corpo e la mente, consumati dalla fatica di resistere a se stessi, possono sopravvivere all’incertezza di esserci; sepolture estreme della solitudine in cui il sangue e la carne, messi alla prova, non sempre desistono, in quanto in alcuni “incerti” appare chiara la percezione che se anche “la terra stia finendo […]“ “resta ancora tanta aria da scavare”2.
Il confino forzato nella malattia, per cui, ad un certo punto, “finalmente la morte dimette il matto”3, è come la segregazione ineluttabile dentro la parola, in quel dire, in versi, soffocante ma necessario che “tiene in pugno”4, spesso in scacco, fino al raggiungimento del desiderio estremo di divenire ciechi, muti e sordi. Il sacrificio di respirare nella parola chiede di “poter cadere all’infinito”5, pare voler dire Brancale, ma, solitamente, le cadute, da un punto così alto, fracassano le ossa, producono carcasse, generano esseri monchi e senza fiato. I suoi versi, allora, tentano di salvare il menomato incerto, indicandogli la via del ritorno, pur avvertendolo che“la storia di una lacrima è destino dell’occhio”6.
La morte quotidiana del poeta, sempre “sottomesso a una parola muta”7, ma incisa a sangue, resta condizione imprescindibile di questa scrittura, in quanto“ il sangue non desiste, rivendica l’istante”8 che si svolge, forse, in un “dormiveglia”9, e spesso nell’incertezza di essere sopravvissuti o seppelliti. In questo esistere sì fatto, però, “l’uomo ha ancora una chance”10, assicura l’autore, in quanto l’individuo resta “una duna sul punto dell’orizzonte, soglia dove praticare parole d’oblio”11.
“Sono morto troppe volte credendo e aspettando … ”, ripeteva anche Charles Bukowski, quasi parafrasando il destino di morte e di resurrezione spettante a coloro che di parola vivono, benché consapevoli, direbbe Brancale, che “scrivere è derivare”12.
A quella figlia, prematuramente orfana di padre, con quel suo fare da “santo anarchico“13, Sandro Penna avrebbe mormorato: di fatto “‘morti eravamo e senza alcun sospetto’“14, e, forse, rimane questa l’unica condizione possibile per sopravvivere tra i vivi, vera pratica di quell’umanità incerta di cui scrive Brancale. Tra le sue righe, solchi del dire, sembra di scorgere il racconto di quella medesima “tenerezza della miseria umana”15, attribuita da Pasolini a Penna, così come appare in quell’immagine desolata, cupa, scomposta, restituitaci da Mario Schifano in “Umano non Umano”16. Un Penna sofferente, povero, scordato dalla vita e abbandonato su un vecchio letto, che confessa tremolante di non sapere bene “se stia nascendo o morendo”. Nel film, strutturato per dicotomia,”si fa presto a capire dove stia l’’umano’ e il ‘non-umano’. Il primo sta nel Vietnam, in forma di unità di pensiero e azione, di teoria e pratica. Il secondo sta invece nel mondo occidentale, in forma di disunità, velleità, frammentarietà”17.
Nella vita, per certi aspetti anch’essa dicotomica, l’umanità si trova là, dove si spezza il pane con l’altro, nel luogo in cui si offre il letto allo straniero pellegrino e mentre si stringe la mano all’”incerto”; così, per antitesi, pare evidente anche il posto buio occupato dalla disumanità: canceroso interstizio in cui “umano non è più dell’essere”18 e spazio dove l’uomo dimentica che la sua esistenza è possibile solo nella sussunzione con l’altro nel sé.
In questa zona d’oblio, in cui l’altro è solo clandestino, facilmente si trasforma il bisogno dello straniero in colpa, condannando il miserabile per ciò che non ha mai avuto e soffocando con l’odio il gemito della disperazione. Di tanti disperati, figli dell’uomo, l’Occidente ha saputo farne carne da macello, trasformandoli in corpi umiliati, affamati spogliati e reclusi in gabbie di “permanenza temporanea”, o in lager di “identificazione”; così, la loro identità è forgiata da “carcerieri di viaggiatori”19 e l’”umano” dimostra, senza vergogna, la sua condannabile e riprovevole incertezza, mentre i “colpevoli di viaggio”20, nudi, stuprati, ingravidati, senza nome, senza terra, strepitano silenziosi: “Lastricheremo di corpi il vostro mare per camminarci sopra. […] Faremo i servi, i figli che non fate”21.

Nel libro di Brancale l’umanità che appartiene ai suoi esseri di parole, divenuti carne, si spolpa nella volontà di vivere fino a scorticarsi, dimentica di respirare nell’affanno di correre, e appare ombra tra le ombre consumate e senza volto. Frammentati, spezzati, soli, ma, tuttavia, resistenti, i suoi incerti, “sopravvissuti morti”22, vacillano alla ricerca cieca di un sentimento, o di una pratica passionale da consumare fino allo sfinimento. Dopo il combattimento con lo specchio di se stessi, che diviene anche lotta con l’Altro, restano le ossa, il midollo, lo scheletro di chi ha vissuto senza risparmiarsi nulla, ma rimane anche il dubbio se per questo fine davvero valesse la pena giocarsi la pelle. La sagoma di queste anime penitenti resta impenetrabile fino alla fine, e per tutto il libro ci si domanda se “incerti”, questi umani, siano portatori condannabili di un’incerta umanità, o, piuttosto, di un’umanità encomiabile come certezza, rara, cresciuta solo “in-certi” umani. Esiste anche una terza possibilità, cioè che questi umani appaiano al mondo, equilibristi, scoprendosi deboli, dubitanti, malfermi, appunto, semplicemente incerti sulle orme del loro cammino. In realtà, sono questi gli umani cui pensa l’autore, presenze tumefatte dal desiderio di restare, crani che ancora respirano e riflettono pur sapendo che “c’è una taglia sulla loro [nostra] volontà”23.
Brancale squarta l’esistenza, in quel punto caldo, dolente, turgido, per il quale alcuni esseri si ammazzano, o finiscono in un angolo, come cani, a morirne in solitudine.
Le parole affondano, scavano, “esplodono” senza interruzione, dall’inizio alla fine del libro, sbragano il “congedo” di chi tenta di amare anche nel commiato che, a sua a volta, dilania. L’Amore di cui racconta l’autore, che pare via salvifica del poeta e dell’essere, persiste in tutti quegli Umani incerti, dove l’umanità si trasforma in un assolo impossibile, in cui la realtà di un sentimento svanisce nella vanità di un canto a due voci destinato a perire della propria passione. È l’umanità dell’incerto, vacillante, funambolo irrimediabilmente innamorato, barcollante e ciondolante, alla ricerca del tormento passionale che, appena pronunciato, già si trova dissolto tra le righe; tuttavia, al poeta, sembra inevitabile che“noi percorriamo la carne di chi amiamo. Noi fiati. Verso questo restare”24.
Ecco, dunque, svelarsi i volti di questi umani disossati dall’amore che camminando all’indietro, sulla “via del pane”, combattono per rinvenire un frammento di loro e, così, restano incurabili solitari, erranti aliti senza viso che procedono convinti, come Victor Hugo, che “l‘amore non abbia mezzi termini; o perde, o salva”. Esseri che scavano la loro fossa quotidiana, pensando che la salvezza possa vivere nel respiro dell’altro, nel rapporto tra l’io e il tu, confidando così in quel diritto, su cui conta anche Brancale, per cui, insieme alla legittimità di “contraddirsi” e di “andarsene” per sempre, come scriveva Baudelaire25, resta però “irrevocabile” anche il diritto che “non si possa fare a meno dell’altro”26.
Questi incerti peccatori senza unghie, giunti stremati alla soglia del sentire, ingobbiti dalla colpa d’amare, implorano al poeta pietà e perdono; tuttavia, nessuno può salvare chi alla carne si è sacrificato, nessuno può redimere colui che ha scelto di vivere morendo e l’incerto è destinato solamente a perire del suo tormento, bevendo le lacrime di chi non esiste più o forse di chi non è mai esistito. Per l’Incerto, amare l’altro significa esserci, corrisponde a rinascere continuamente nelle vertebre e nell’animo del tu; in realtà, egli non ha ben compreso che ”l’Eros sfrenato è altrettanto funesto del suo antagonista, l’istinto di morte …”27, e, quindi, maldestramente, corre consapevole, senza occhi e con la bocca oramai cucita, verso un orizzonte di fine, dove potrà ascoltare solo la polvere delle sue ossa e non quelle dell’Altro. Il poeta non ha dubbi: la disperazione degli amanti per i loro ricordi non si cancella, e “spesso i nostri passi indietreggiano verso le orme di ciò che non vorremmo mai fosse dimenticato.” “ L’illusione – scrive Brancale – resta la terra ferma più crudele eppure tocca baciarla dopo l’ennesimo naufragio.”28
E allora la strada dell’incontro con l’altro, percorribile, autentica, rimane quella del noi, sul confine liminale, dove l’Io ingravida i molti; qui l’Umanità, dopo l’amplesso d’Amore con l’assoluto, senza pegni da pagare e priva di rinunce o rimpianti, partorisce, certa che i suoi figli ameranno senza tregua in nome del bene comune. Se ad una certezza, però, l’incerto desideri aspirare, deve sapere che Amare il tu lo condurrà, innanzitutto, all’appagamento viscerale del sé; così, chi vive d’amore per primo lascia all’amante solo i resti, riflessi incarnati di questo doloroso parto del sentire.
Tuttavia, anche sul sentiero dell’amore universale, nel punto in cui si porge all’altro in cambio del niente, la sola certezza che ci è consentito raccontare consiste nell’esercizio del non ritorno; la pratica autentica del cambiamento in nome di un noi sta nel non voltarsi indietro nemmeno per accelerare, e nel continuare a toccare la terra di quegli ideali senza i quali non varrebbe la pena di respirare29.
“… Avanzare è d’obbligo”30.
[1] A. Celestini, La pecora nera. Il diario, Einaudi, Torino, 2010, p. 81.
[2] D. Brancale, 7.6.2011. Tutte le citazioni di questo tipo sono frammenti inediti di corrispondenze private tra chi scrive e l’autore di incerti umani.
[3] A. Celestini, La pecora nera, op. cit., p. 67.
[4] D. Brancale, 28.11.2011.
[5] D. Brancale, incerti umani, Passigli Poesia, Firenze, 2013, p. 27.
[6] Ibidem, p.47.
[7] D. Brancale, 20.6.2011.
[8] D. Brancale, 4.8.2011.
[9] Frase di Sandro Penna, cit. da: 1h 07’ a 1h 22’, in M. Schifano, “Umano non Umano”, 1969.
[10] D. Brancale, 4.8.2011.
[11] D. Brancale, 5.8.2012.
[12] D. Brancale, incerti, op. cit., p. 38.
[13] P. P. Pasolini, Lettera di Pier Paolo Pasolini a Sandro Penna, Roma, febbraio 1970, in Pier Paolo Pasolini, Vita attraverso le lettere, (a cura di N. Naldini), Einaudi, Torino 1994.
[14] S. Penna, Poesie, Garzanti, Milano, 2000.
[15] Ibidem.
[16] M. Schifano, “Umano non Umano”, 1969.
[17] A. Moravia, “ Il vietcong nel salotto hippy (un film di Mario Schifano)”, in “L’Espresso”, 25 febbraio 1973.
[18] D. Brancale, incerti, op. cit., p. 18.
[19] E. De Luca, in “Migranti, Erri De Luca: noi, carcerieri di viaggiatori “, in “Libre. Associazioni di idee”, 23 ottobre 2010.
[20] Ibidem.
[21] Ibidem.
[22] D. Brancale, incerti, op. cit., p. 76.
[23] D. Brancale, 3.1.2012.
[24] D. Brancale, 24.12.2011.
[25] Cfr. C. Baudelaire, Edgar Allan Poe, la vita e le opere, in Scritti critici, Pendragon, Bologna, 2004, p. 90.
[26] D. Brancale, 9.11.2011.
[27] H. Marcuse, Eros e Civiltà, Einaudi, Torino, 1974, p. 59.
[28] D. Brancale, 4.2.2012.
[29] Cfr. E. Che Guevara: “Vale la pena di lottare solo per le cose senza le quali non vale la pena di vivere”.
[30] D. Brancale, 4.2.2012.
__________________________________
*
essere mio rinato
disseminato
vento regnante nell’ora predetta
forza sette, era di fiato il mare
l’ora in cui stringemmo i nodi
dieci, mare forza dieci
era noi
stessi mai più
l’essere sferzato non consola
l’essere amato di più
vedi come non c’è certezza nei campi
alla fine non altro
fiatore
nei miei polmoni c’è l’attesa
distanza mantenuta promessa
di vertebra lesa
e adesso consumato lo sguardo
*
tempia a tempia con l’argilla
cera a sole
lontano dalla portata delle mani
lontano dalla portata dell’aorta
in questo perenne
sangue aperto
incorporato
devi
restare
in quanto essere scritto
porta la tua erranza verso il terreno crepato
così in disparte
nelle promesse di un miraggio
in cui l’occhio ha rassegnato per sempre la vista
afferma il tuo frammento
di nostri incerti umani
*
nessuna voce franca
nessun luogo di respirazione
qui è un qualcuno a credere al sale degli occhi
qui messo a dimora
vuoto preso in parola
tu nella ripetizione a mente per confondere io
attraverso questo essere irrimediabilmente traccia
fossile
a predire il cammino
udibile a malapena
nell’orma vuota che giace sotto i passi
l’istante è varco e diga
lungosenna del volto
di uno che annega parlando con la «colpa dell’amore»
accanto alle proprie mura edificate
convivendo macerie
ai margini d’infinite pupille
volto all’assente
spietrato
dalla lingua corrente che annoda
*
strappato da qualunque argine
indetto a muta perenne
ora che un nonnulla t’incera le mani
l’esilio è sotto l’unghia incarnita della notte
avevo appena versato le negre lacrime prime
non avrei mai dovuto imparare a sparlare
a fingermi tu …
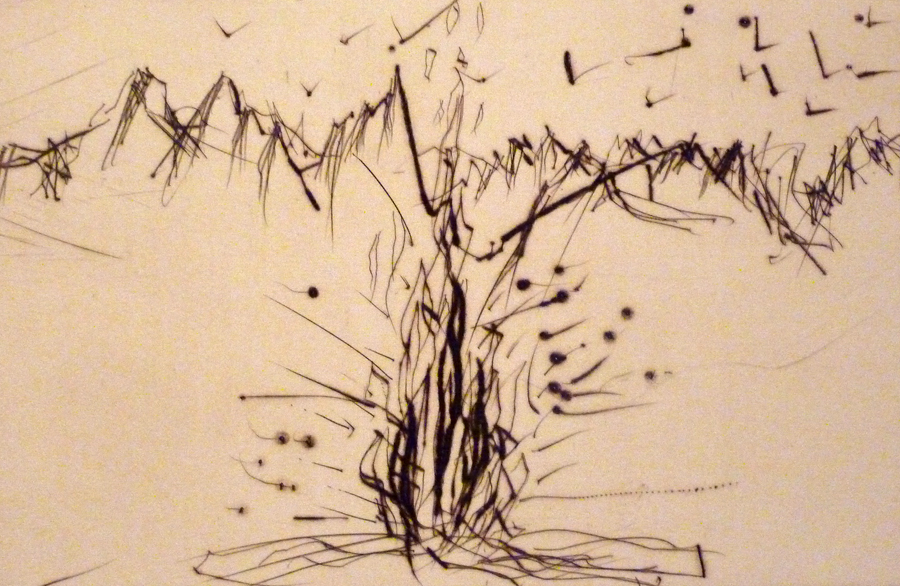
puntasecca
*
una volta fatto tu nella disperazione
non scordare la lingua che divora il cuore
assoluta in ogni ragione
lingua di gesso scalfita a nero
già lingua ostinata di penitenza
tizzone di ogni tuo stato tradimento
oramai tu
afferra quel che rimane spento nella luce
ciò che marchiato sulla cera del viso
oggi ti sbarra la via
radicato a pelle
«un mal d’aurora»
lì fu una ferita
nella ferita il segno che il silenzio parla pure
lì fu una mano
nella tua sempre più ultima mano
la carezza che annulla l’abisso
dentro qualcuno l’eco concede che sia tu stesso
a riarginare lo spiraglio
*
chissà se la luce che pianta nel petto
dei giorni a venire
l’orizzonte
sferza
assolve
le orme dell’ombra di qualunque estraneo cammino
la prima luce sonora calata nella goccia
l’umiltà d’argilla
la dispersione il paesaggio
da un giorno all’altro
la nostra svolta saremo
carne in questo immolato infinito canto
chiamati ancora a vivere
l’ennesimo atto
«vivi dentro la morte»
distesa di questi e altri passi
come se essere lì delineasse il luogo
eventuale di ogni distanza
*
la notte
quella versata sulle labbra
tua più di ogni bocca
la notte di cera
che trabocca dalle ciglia
tua più di ogni occhio
dove non può arrivare il giorno
giunge la mia mano
dove non può stringere
è già tua la morsa
perché se ti allontani io qui resto
alle tue gambe
un passo che non cede
possiamo
sull’orma dove germoglia la carne
possiamo
tu altro di me un malessere che appaga
qui solchiamo le schiene
(proprio qui dove matura segreto e compassione)
*
so’ angòre qquà
presente
sempe ppa mane ndu vrazze gauzàte
pronte a dìce
assente
luntane d’ ’a cènnere ca l’appartène
[………………………………….]
*
(se bastasse l’oblio, se almeno bastasse per mettere a
fuoco quell’unico punto dove il luogo non ha più dimora,
dove il verso non dichiara direzione…. nel vicinato
nulla… presso quel sempre cominciamento… a finire…
in cui fiato e sangue impastano lo scafo del nostro avvenuto…
in quella periferia lontana indiscriminata anima
al largo di un possibile incontro… se solo ci fosse
nell’oblio un solo spiraglio per la memoria… di cedere…
di cedere… di cedere…. se solo bastasse la cancellatura di
ogni debita distanza… se tu fossi qui e io smettessi di
dire tu… qui immediatamente… portando ogni mio arto
dentro il tuo… ognuno alle prese con le proprie giunture…
a farsi innesti… essendo illimiti… avverandosi al di
là della nostra pietanza… e tu smettessi di essere qui…
dove saprei solo… essendo diverso dove
ora voltarti
ora prenderti
ora stretta
ora scavi
ora vene
… e poi tacere fino al prossimo sussurro dell’attimo
vivo… l’orizzonte in luogo di noi… eufrasia…)
*
un’unghiatura nella corteccia quasi trasparente
ovunque io guardi
quello che rimane invero da strappare
la veglia l’insonnia l’ombra
l’identità di quella traccia grigia
l’angolo in corpo in cui si ammassa la cenere
come se mai alla mente bastasse fuoco
mai nei pressi di un firmamento
ti appello a non rinunciare alle stelle
questo e nient’altro deve essere eseguito
nella veglia del giorno
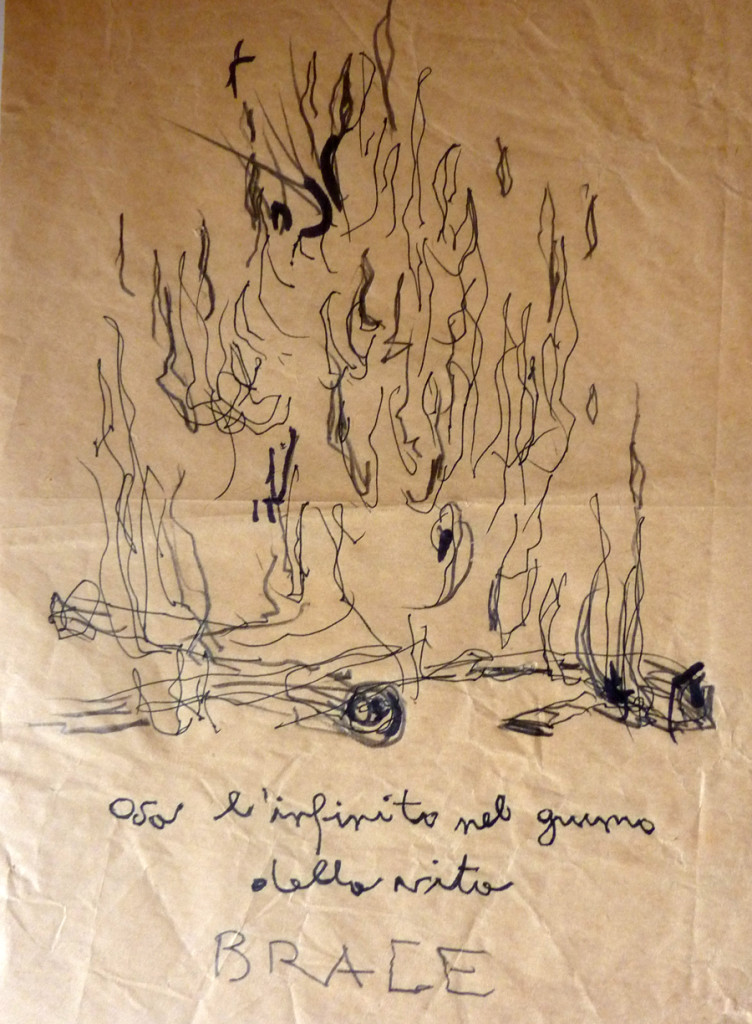
Gisella Vismara, nata nel 1977; dal 2006, è docente presso l’Accademia di Belle Arti di Brera (Milano), per l’insegnamento di Didattica per il Museo. Dopo la laurea al DAMS di Bologna e l’abilitazione SSIS in Storia dell’Arte ha effettuato diverse esperienze nel settore della didattica per adulti e ragazzi: ha lavorato per Palazzo Magnani di Reggio Emilia, per il Palazzo delle Esposizioni di Roma e ha collaborato con Palazzo Poggi di Bologna. Ha fatto parte del comitato redazionale della rivista di didattica dell’arte Dada, contribuendo anche all’edizione del libro I laboratori di Artefatta per la casa editrice ARTEBAMBINI di Bazzano (Bologna); per la stessa ha condotto diversi laboratori didattici presso biblioteche e scuole. Per la Fondazione Lucio Saffaro di Bologna ha svolto e svolge lavoro di catalogazione e studio del materiale artistico e letterario edito ed ancora inedito dell’artista Lucio Saffaro.
Domenico Brancale è nato il 5 giungo 1976 a Sant’Arcangelo (Basilicata). Vive a Bologna e Venezia. Ha pubblicato: Cani e porci (2001, Ripostes),L’ossario del sole (Passigli, 2007), Controre (Effigie, 2013), incerti umani(Passigli, 2013). Ha curato il libro Cristina Campo In immagini e parole(Ripostes, 2002), e tradotto Cioran, Michaux, John Giorno, Claude Royet-Journoud, Victoria Xardel.
Giacinto Cerone (Melfi 1957 – 2004 Roma) dopo aver frequentato il Liceo Artistico, si trasferisce a Roma dove termina gli studi di scultura presso l’Accademia di Belle Arti con Umberto Mastroianni e Pericle Fazzini. Dal 1976 al 1980 vive tra Roma e la Lucania. A Roma, presso l’amico Giuseppe Appella frequenta lo Studio Internazionale di Arte Grafica l’Arco. Nel 1984, con la moglie Elena Cavallo, si trasferisce definitivamente a Roma aprendo lo studio in Vicolo del Bologna, successivamente in San Lorenzo, poi in Santa Croce in Gerusalemme.
La sua produzione artistica si esprime nell’uso di diversi materiali come legno, gesso, plastica (moplen), ceramica, ghisa e marmo.

Lascia un commento